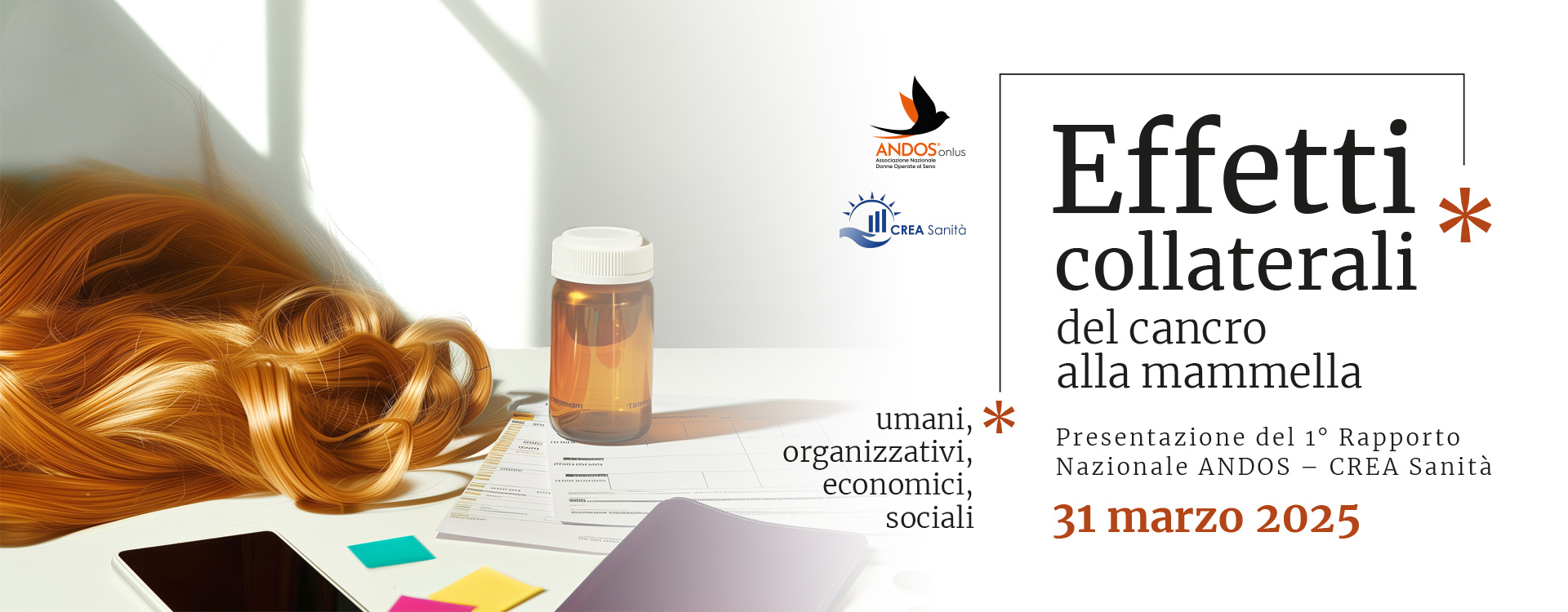La survey “Effetti collaterali* del cancro alla mammella *umani, organizzativi, economici e sociali” è stata sviluppata congiuntamente da ANDOS e C.R.E.A. Sanità con la finalità di far emergere l’esperienza e le aspettative delle donne che hanno dovuto affrontare il tumore al seno.
L’analisi nasce dalla consapevolezza da parte di ANDOS che il percorso di una donna operata di carcinoma mammario è lungo e articolato, ed anche fortemente impattante sulla quotidianità di vita.
L’eventuale trattamento chirurgico ne rappresenta una fase circoscritta: può essere infatti preceduto o seguito da complesse e invasive terapie farmacologiche neoadiuvanti o adiuvanti, radioterapia, in molti casi da anni di trattamento ormonale e la possibile evoluzione di malattia e/o cronicizzazione.
Durante tutto il percorso si producono “effetti collaterali” clinici e sociali più o meno impattanti, che rischiano di compromettere significativamente la qualità di vita delle pazienti, peraltro in larga misura ancora in età lavorativa.
C.R.E.A. Sanità ha con grande piacere e interesse aderito alla proposta di ANDOS di collaborare alla predisposizione di una survey destinata alle donne associate, perché da sempre convinta dell’importanza della centralità del paziente nel percorso di cura: condizione che si può realizzare solo conoscendo la “persona” che c’è dietro il “paziente”, con le sue ragioni, volontà, sentimenti e bisogni, e coinvolgendola come partner attivo nella cura.
Comprendere quali siano le aspettative e le criticità che la donna deve affrontare permette, in definitiva, di migliorare i servizi sanitari, promuovendo un sistema socio-sanitario capace di integrare gli interventi e curare olisticamente insieme la patologia e la persona, indipendentemente dal suo luogo di residenza, dall’età e dal livello culturale.
La survey, diffusa da ANDOS, per mezzo dei canali social, fra le donne associate, ha voluto rilevare:
- le caratteristiche anagrafiche e socio-economiche delle donne (e delle relative famiglie);
- l’impatto organizzativo relativo alla gestione della patologia, in particolare in tema di accesso e presa in carico;
- l’impatto della patologia sulle condizioni psico-fisiche, sulla qualità della vita e sulle proiezioni della propria condizione delle donne;
- la spesa privata sostenuta per la cura della patologia e i costi indiretti generati;
- l’impatto socio-economico della patologia e la sua tossicità finanziaria.
La partecipazione è stata totalmente volontaria e anonima e autosomministrata con il metodo CASIC (Computer Assisted Survey Information Collection).
Alla survey hanno acceduto 1.494 donne e di queste il 39,2% (585) ha completato il questionario.
Pur con la consapevolezza che il campione di risposte raccolte non è necessariamente statisticamente rappresentativo, ha permesso di evidenziare importanti temi di riflessione per le politiche sanitarie e sociali.
Accesso alle Cure e Figure di Riferimento
Partendo dall’accesso alle cure, la survey ha permesso di evidenziare come l’oncologo rappresenti, per oltre due terzi delle pazienti, la figura di riferimento della donna; seguono il chirurgo (7,7%) ed il Medico di Medicina Generale (MMG) (5,5%).
Il riferimento al MMG si osserva nel caso delle pazienti più anziane e che hanno ricevuto una diagnosi da più tempo.
Complessivamente, emerge un basso livello di interazione tra l’assistenza specialistica e il territorio (MMG) generalizzato in tutte le ripartizioni geografiche, ma in particolare in quella del Centro.
Follow-up e Prenotazioni delle Prestazioni
Per quel che concerne gli esami di follow-up, a meno della metà delle pazienti vengono prenotati direttamente dal Centro o dal medico che le ha in carico: la pratica è più frequente nel Nord. La quota delle donne che prenotano autonomamente le prestazioni aumenta con l’anzianità di diagnosi.
Malgrado non emergano particolari problemi in termini di rispetto dei tempi previsti per gli esami di follow-up (quasi il 90% delle pazienti riesce ad effettuarli nei tempi previsti), due terzi delle rispondenti, ed in particolare le residenti nel Centro, lamentano difficoltà nella prenotazione delle prestazioni.
Le liste d’attesa sono il principale problema, soprattutto nel Sud e Isole; una pari quota di pazienti ha dichiarato di essere stata costretta a rivolgersi al privato: quota che aumenta con il livello di istruzione (che rappresenta statisticamente anche una proxy del reddito) delle pazienti, sebbene non sia marginale il ricorso al privato da parte di quelle con minore titolo di studio e, quindi, presumibilmente meno abbienti.
Distanza dai Centri di Cura
La distanza dai Centri di cura è un altro problema che le donne si trovano a dover affrontare. Il 36,4% delle donne lamenta una lontananza dello stesso dal luogo di residenza e il 32,1% i costi di trasporto per raggiungerlo; in media, le donne percorrono 86 km per il tragitto di andata e ritorno per recarsi nella struttura di cura, e lo fa mediamente 2,3 volte al mese.
Qualità della Vita delle Pazienti
La qualità della vita delle donne partecipanti alla survey, rilevata con l’EQ-5D-5L, è risultata in media pari a 0,78, valore in media inferiore rispetto alle donne della popolazione generale tra i 18 e i 74 anni (0,90). La qualità della vita delle donne partecipanti alla survey è inferiore altresì alla media dei pazienti con epatite cronica (0,90 QALY), cirrosi (0,82 QALY), carcinoma epatocellulare (0,80 QALY) e trapianto ortotopico di fegato (0,83 QALY).
Si è ritenuto opportuno completare le valutazioni sulla qualità della vita delle pazienti, indagando sulla percezione che hanno della propria situazione emotiva.
In particolare, si segnalano la solitudine e l’isolamento di cui 10,6% delle rispondenti dichiara di soffrire molto o moltissimo; le difficoltà relazionali che si trovano a dover affrontare il 16,2% delle donne che hanno aderito alla survey; il 23,1% delle donne inoltre ha timore del giudizio degli altri e il 27,0% soffre di una scarsa autostima.
Si nota un gradiente legato all’età e all’anzianità di diagnosi: soffrono maggiormente di queste difficoltà emotive le donne sotto i 40 anni e quelle diagnosticate da meno di 2 anni.
Le problematiche segnalate sembrano altresì incidere diversamente a livello di ripartizioni geografiche: nello specifico più nel Sud del Paese che nel Nord e Centro.
Altro elemento degno di nota riguarda le preoccupazioni che le donne hanno relativamente al proprio futuro: il 27,9% è molto o moltissimo preoccupata per la crescente gravità dei sintomi e il 36,8% abbastanza; il 26,0% è molto o moltissimo preoccupata per il rischio di maturare una invalidità fisica e il 31,1% abbastanza; il 27,9% molto o moltissimo preoccupata per l’emergere o peggiorare del dolore fisico e il 36,4% abbastanza; quasi il 60% delle donne teme la futura compromissione dei propri organi.
Sempre prospetticamente, quasi il 30% delle donne teme di poter rimanere disoccupata a causa della malattia e tali preoccupazioni appaiono più marcate tra le donne giovani e quelle con diagnosi più recente.
Quasi la metà delle donne con meno di 40 anni (42,9%) è molto o moltissimo condizionata nella decisione di avere figli.
In positivo, il 60% delle donne dichiara di ricevere molto o moltissimo sostegno, soprattutto dalla famiglia, e il 33,9% delle donne dichiara di ricevere molto o moltissimo sostegno dagli amici. Anche il ruolo dell’associazione pazienti appare importante nel dare sostegno alle donne: dichiarano di riceverne molto o moltissimo il 31,5% delle rispondenti e abbastanza il 25,8%.
Supporto psicologico e coinvolgimento dei caregiver
Meno del 10% delle donne intervistate ritiene che il supporto psicologico effettivamente ricevuto sia di molto o moltissimo sostegno; la percentuale aumenta nelle donne più giovani (25,0% delle donne con meno di 40 anni e 16,0% delle donne con età compresa tra 41 e 60 anni). Si noti che il caregiver è stato coinvolto nel supporto psicologico nel 31,6% dei casi: si passa dal 75,0% dei caregiver nel Nord-Ovest al 16,7% nel Centro, così come anche nel Sud e Isole; non di meno, solo nel 10,5% dei casi il caregiver ha ricevuto un supporto psicologico specificatamente dedicato: questo è avvenuto nel 25,0% dei casi nel Nord Ovest e nel 16,7% nel Centro, mentre non si riscontra né nel Nord-Est né nel Sud e Isole.
Il supporto dell’ambiente lavorativo e spese private
L’ambiente lavorativo (inteso tanto in termini di colleghi, che di datore di lavoro), ma anche di welfare aziendale, appare meno “presente” nel supportare le donne, peraltro con marcate differenze tra il Nord e il Sud del Paese. Oltre il 70% delle donne rispondenti ha dovuto sostenere spese private nel suo percorso di cura. Il fenomeno coinvolge soprattutto le residenti nel Centro e nel Sud, giovani e con una diagnosi recente di tumore. La quota di donne che spende privatamente per curarsi aumenta con il crescere del livello di istruzione (proxy del reddito).
Spese sostenute e distribuzione geografica
La spesa media annua sostenuta è pari a € 1.233, ovvero pari a € 1.665,8 riferendo il dato alle sole donne che le hanno sostenute: quella delle rispondenti del Sud è circa sei volte quella sostenuta da quelle del Nord-Est, e raggiunge il livello massimo nelle donne di età compresa tra 41 e 50 anni. I farmaci, oltre che l’acquisto diretto riscontrato con maggiore frequenza, sono anche la voce di spesa più impattante sui bilanci familiari, assorbendo il 40,8% della spesa sostenuta privatamente (€ 502,8); seguono con il 14,7% le visite specialistiche a pagamento, con un onere annuo di € 181,6, e i trattamenti di fisioterapia e riabilitazione, che incidono per il 10,5% (€ 129,1).
Altre spese e difficoltà economiche
I ricoveri a pagamento, sebbene “rari”, sono unitariamente costosi, incidendo in media per il 6,0% sulla spesa diretta annua: € 73,7 di cui il 34,8%, pari a € 26,7, per compartecipazioni. Infine, registriamo che il 5,7% è attribuibile al pagamento di presidi medici e protesici (€ 70,3 di cui il 37,9%, ovvero € 26,7, per compartecipazioni), mentre minore incidenza è riferibile ai servizi di assistenza domiciliare a pagamento (0,2%, ovvero € 1,9). A tali spese si affiancano quelle non sanitarie, quali quelle per gli adattamenti dell’abitazione e i trasporti che incidono rispettivamente per l’1,4% (€ 17,3) e lo 0,9%, (€ 11,3).
Assicurazione, credito e impatti sociali
Nonostante la quasi totalità delle pazienti siano esenti dalle compartecipazioni, nelle fasce giovanili e soprattutto nel Nord del Paese, circa il 15% delle rispondenti ha ritenuto opportuno dotarsi di copertura aggiuntiva mediante polizze assicurative. La condizione di paziente genera, però, varie forme di discriminazione: a una quota rilevante di donne non è stata concessa copertura assicurativa, come anche è stato negato l’accesso al credito a causa della propria condizione clinica. Inoltre, il 20,7% delle rispondenti ha dichiarato di aver dovuto intaccare fonti di risparmio (es. TFR, investimenti, fondi, ecc.) per far fronte alle spese sanitarie.
Impatto sul lavoro e sulla vita sociale
L’impatto della condizione ha effetto anche a livello sociale: a causa della patologia nell’ultimo anno le donne intervistate hanno perso in media circa 20 giornate di lavoro/studio e per 15,2 giornate hanno avuto una ridotta produttività, ed hanno dovuto avvalersi di supporto per le attività domestiche per 27 giornate nell’anno. Inoltre, i loro caregiver hanno perso in media 11 giornate nell’anno per fornire supporto. Il 13,2% delle donne che ha avuto un’occupazione o sta portando avanti un percorso di studi, si è trovata per motivi legati al tumore alla mammella nella condizione di dover cambiare lavoro o percorso; il 27,0% delle donne si è trovata, nella condizione di dover sviluppare nuove abilità; il 40,5% delle donne si è trovata a ridurre le ore di lavoro. Tali problematiche si sono riscontrate principalmente nel Sud e Isole.
Tossicità finanziaria e impatti complessivi
Per mezzo del questionario PROFFIT si è, infine, indagata la tossicità finanziaria prodotta dalla patologia, stimando che colpisca il 38% delle donne. Con il termine “Tossicità finanziaria” si definiscono le conseguenze economiche che la malattia (in questo caso oncologica) e i trattamenti da essa derivanti, determinano sul paziente, sia in termini oggettivi, che soggettivi. Viene utilizzato il termine “Tossicità” per sottolineare come gli effetti derivino direttamente dalla malattia e dai relativi trattamenti, al pari di quelli delle altre tossicità cliniche.
Conclusioni
In definitiva, la survey ha confermato e quantificato l’impatto psicologico, sociale, economico della patologia; il tumore al seno rimane un’esperienza fortemente impattante, come anche la risposta del servizio sanitario significativamente migliorabile. Avere fatto emergere caratteristiche, aspettative, difficoltà delle persone affette dal carcinoma mammario, fornisce le conoscenze essenziali per supportare efficacemente politiche sanitarie capaci di mettere davvero le donne al centro del loro percorso di cura.